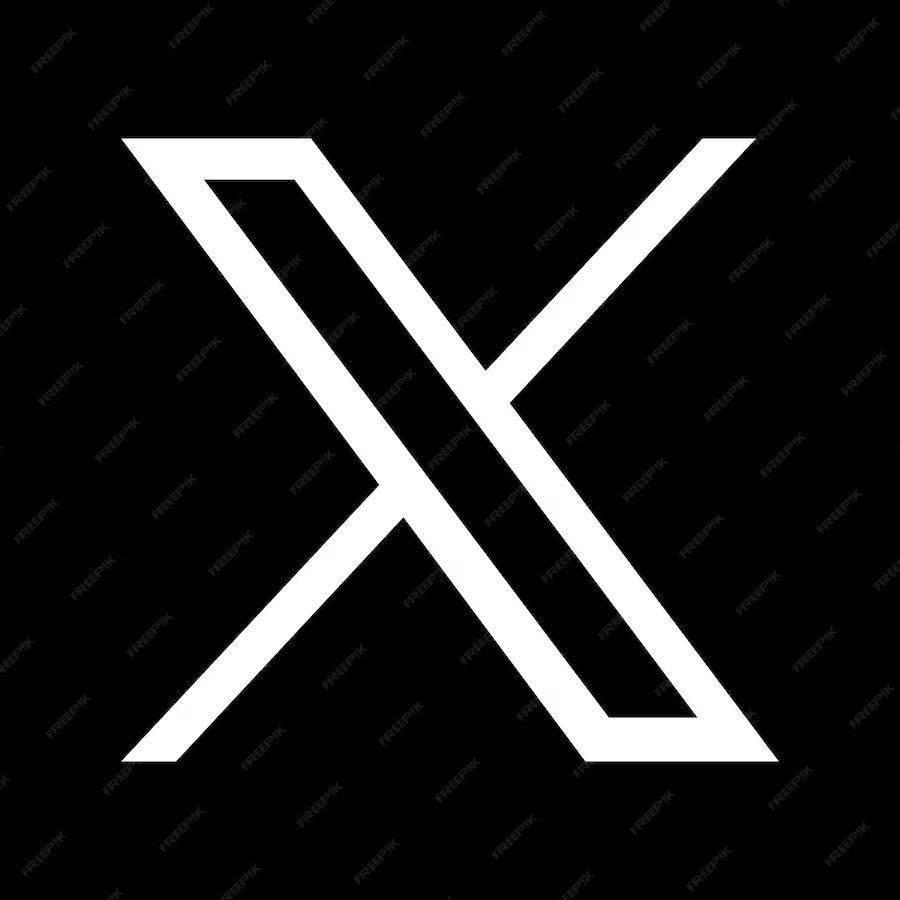Ha collezionato undici Ottomila, Alex Txicon, con la straordinaria impresa invernale del 2016 sul Nanga Parbat, nota anche come “la montagna assassina”. Eppure per lui, «non può essere definita in questo modo, perché è uno dei luoghi più belli del mondo, che ospita popolazioni e persone meravigliose. La chiamiamo “assassina” per i molti morti che ha mietuto, ma la morte, nell’alpinismo, non è che l’1% di un percorso fatto prima, e dopo, di grandi momenti, di imprese, di errori e di conquiste». Comunque lo si voglia appellare, il Nanga Parbat rimane un monte con grandi distanze tra campo base e vetta, con grandi pendenze e molte insidie, e scalarlo d’inverno, ammette, «non è stato affatto semplice: non c’era solo il freddo, ma anche una grande serie di cambiamenti climatici (che nel tempo stanno diventando sempre più imprevedibili), e ancora il ghiaccio, la fatica, le dita dei piedi doloranti durante il cammino». Arrivare in vetta, allora, per Txicon non è l’impresa eroica, «non è qualcosa che si fa per gli altri, ma per se stessi soltanto, ammettendo – e io lo ammetto – anche di aver paura, di voler scendere. Gli alpinisti, e tutto il mondo che vi ruota attorno, a mio avviso ricerca la felicità nel luogo sbagliato, nell’individualismo, nella vittoria, ma non è soltanto questo a dover essere premiato, bensì anche i tentativi, per non parlare del team di amici, familiari e supporter alle spalle di ognuno». La vetta, insomma, non deve essere «un’ossessione, ma un momento». E lo spagnolo lo dimostra anche nella concretezza delle sue spedizioni, spesso affiancate alla conoscenza della gente del luogo, nonché all’aiuto, come quando porta con sé cellule fotovoltaiche per far sì che i piccoli villaggi possano avere luce.
Non meno significativo, nel suo approccio alla scalata, alla ricerca del limite, è il senso di profonda malinconia con cui osserva le cose: «La morte in montagna è crudele, e per me è sempre un fallimento tornare con meno compagni di quando sono partito» - racconta, per poi ricordare la ricerca dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard, sempre in quell’occasione. «Come potevo rifiutarmi? Però sapevo di stare mettendo la testa nella bocca del lupo. Ho avuto paura, soprattutto quando mi trovato lungo lo sperone Mammeri, accucciato, con una valanga che scorreva sopra la mia testa – continua -. I corpi, per fortuna, furono ritrovati, ma non posso descrivere il dolore di aver tenuto in mano gli averi di amici che non c’erano più, di parlare con le loro famiglie». Compagni per i quali desidera tenere accesa la memoria, «affinché possano continuare a vivere, come pezzi di una storia, quella dell’alpinismo».