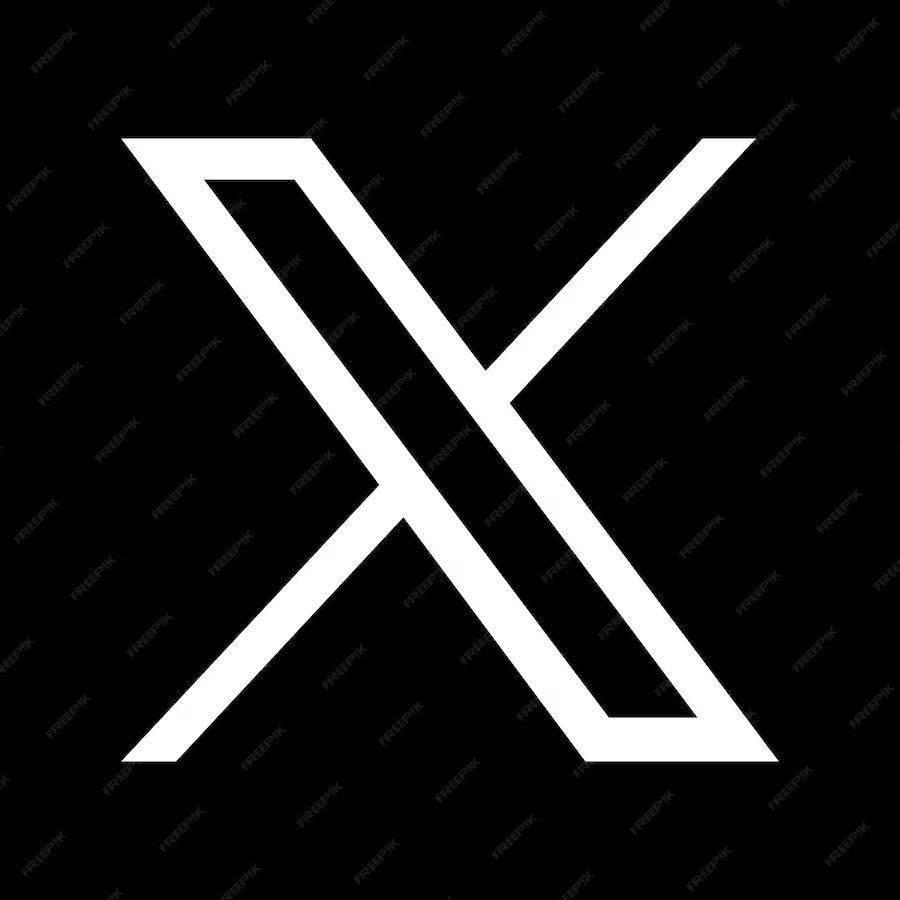«Non conoscevo la storia del soldato Svejk e quindi non sapevo della riduzione teatrale di Brecht. Quando Jacopo ed Elena mi hanno parlato del progetto che stavano realizzando, me ne sono molto incuriosita. Gli ingredienti di partenza c’erano tutti: la possibilità di accostarmi al pensiero brechtiano e al suo linguaggio teatrale; l’autorevolezza del Museo storico del Trentino, promotore principale del progetto, e dei sei esperti che avrebbero proposto diverse chiavi di lettura dei contenuti; la professionalità e la bravura di Laurino e Galvani che hanno condiviso la regia con Marco Rauzi. Ma quanto ho scoperto, conoscendo meglio il progetto e la sua impegnativa realizzazione, mi ha irrimediabilmente conquistata.
Il buon soldato Svejk è matto: il termine è crudo e certamente non tiene conto dell’attenzione che va giustamente riservata al linguaggio quando si raccontano le fatiche e i disagi che appesantiscono le esistenze di molte persone. Ma la potenza provocatoria della “Storia di un buon soldato” giustifica e nobilita questo termine, “matto”, che nel sopore di una comunità che si muove su binari più o meno tracciati, più o meno scelti, accettati per comodità più che per convinzione, suona come un’etichetta di disvalore e una sentenza di rifiuto, paura, scherno. Invece l’amico Svejk (come non sentirlo tale, nell’inconsapevole forza delle sue disarmanti “inadeguatezze”), calato dentro la follia del nazismo – tragico sistema di deliranti certezze capaci di devastare menti, dignità, vite – diventa una variabile ingovernabile che quel sistema può mettere in difficoltà. Svejk non è inquadrabile, la sua personalità sfugge a qualsiasi definizione che risulterebbe comunque inadeguata e angusta. E’ matto, appunto, e da matto incrocia esistenze, situazioni estreme, le inconsistenze dei potenti, le fragilità e le ambiguità di chi subisce, con la “libertà” della sua logica inafferrabile, del suo pensiero fuori da tutto ciò che è noto, scontato, prevedibile.
“La storia di un buon soldato” è un lavoro importante anche per come e con chi è stato realizzato. Produzione televisiva di comunità: così viene definita dagli autori. Perché effettivamente una comunità, principalmente quella della Valle di Non, è stata coinvolta nella sua realizzazione: non solo i protagonisti visibili ma anche tutti coloro che hanno facilitato e sostenuto la messa in scena di un progetto tutt’altro che semplice.
Tutt’altro che semplice per il tema, per la rilettura di un testo brechtiano, per l’individuazione di una location adeguata e per tutti gli intoppi, tecnici e non, che è facile immaginare.
Eppure la vera sfida, secondo me, è stato chiamare a interpretare la lungimirante “follia” brechtiana, persone seguite dal servizio di salute mentale, donne e uomini che la sofferenza psichica l’hanno attraversata davvero fino a sentirla, in molti casi, compagna di viaggio. Gioco facile? Sarebbe da sprovveduti ritenere che, per un matto, interpretare un matto diventi naturale…basta interpretare sè stesso. Chi ha provato, per gioco o per curiosità, anche in piccole impacciate esperienze, a spogliarsi del sé per entrare dentro un altro, sa quanto possa essere difficile. Un cammino da funamboli, su una corda tesa tra la complice frequentazione del sé e l’esplorazione senza rete di un inquietante sconosciuto.
Come sono riusciti, gli autori e registi de “La storia del buon soldato”, ad arrivare all’essenza dei futuri interpreti, fino a tessere una comunicazione ricca di sorprese, rivelazioni, emozioni, scoperte, probabilmente oltre lo sperato?
“Io mi fido di te, vuoi fidarti di me?”. È così che penso l’avvio di una tale avventura condivisa, difficile persino da immaginare. E che cosa può aver significato, per una persona strattonata dal sé dalla sofferenza psichica, vestire i panni sconosciuti, eppure familiari, di chi è diventato protagonista di un racconto lucido fino al disincanto, arguto e melanconico, sguardo drammaticamente profetico?
Ho molto apprezzato i risultati di questo impegno e mi piacerebbe che “La storia di un buon soldato” diventasse patrimonio culturale diffuso, una di quelle esperienze che difficilmente scivolano addosso senza lasciare traccia. Nel bene e nel male: non è necessario che piaccia a tutti. Ma vorrei che il caro Svejk diventasse un, anche se piccolo, fastidioso cuneo nella corazza di certezze di chi nega per difendersi, di chi agita il passato per tornare indietro.
Grazie a tutti per questa emozione».
--
Alcune immagini della serie sono disponibili qui